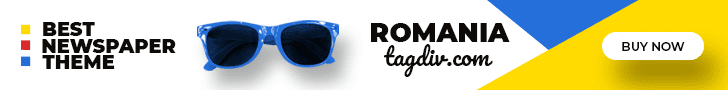Questo articolo è stato pubblicato da questo sito


Generale di brigata aerea, tre volte nello spazio, ha doppiato un androide in Wall-e: queste cose c’entrano molto più di quanto sembri. E il perché riguarda tutta la nostra specie
Anno 2805. In attesa che uno scampolo di vita torni a manifestarsi da qualche parte, siamo sulla Axiom. L’astronave trasporta lontano dal suo pianeta natale l’umanità, fuggita da quella discarica in cui si è trasformata la Terra secoli prima. Negli anni, sulla Axiom, l’uomo è ingrassato dagli automatismi che gli rendono superfluo ogni movimento. Tanto da non riuscire nemmeno a rialzarsi in caso di caduta. Ed è proprio per aiutare uno dei pingui esponenti della nostra specie, scivolato dal suo seggiolino volante e spiaggiato a terra a mo’ di balena, che Wall-e incontra Roberto Vittori.
O, meglio, l’androide da lui doppiato nella versione italiana del film Pixar.
Può sembrare fuorviante presentare così il quarto astronauta italiano – lui, generale di brigata aerea – partendo dal suo cameo nel capolavoro Pixar del 2008. Eppure l’aneddoto lo dice meglio di qualsiasi altra cosa: Vittori ha con lo Spazio una storia d’amore. Lunga e sfaccettata. E, non di meno, sono il genere umano e il nostro pianeta a stargli a cuore quanto il cosmo.
Sarà chiaro in questa intervista, la quarta agli avventurieri italiani dello Spazio dopo quelle a Franco Malerba, Maurizio Cheli e Umberto Guidoni.
Pilota collaudatore, astronauta dell’Agenzia spaziale italiana dal 1998, primo europeo a conseguire la qualifica di comandante della Soyuz, Vittori è stato in orbita tre volte: nel 2002 e nel 2005 a bordo della navetta russa, nel 2011 come mission specialist della Sts-134, l’ultimo lancio dell’orbiter Endeavour e il penultimo del programma Space Shuttle.
Leggi anche
Non solo: dopo aver lavorato, al Johnson Space Center, a supporto della sezione per lo sviluppo dei veicoli spaziali di nuova generazione, ed essere stato membro del team investigativo sull’incidente del Columbia, oggi Vittori è space attaché dell’Ambasciata italiana a Washington, nonché responsabile della locale sede Asi.
Per questo è dura non credergli quando dice che il futuro della nostra specie è legato alle prossime esplorazioni cosmiche.
Vittori, quali erano gli obbiettivi principali delle missioni di cui ha fatto parte?
“Le missioni sono state nel 2002, 2005 e 2011. Conviene ricordare come al tempo procedessero in parallelo due tipi di spedizione: quelle di lunga durata, per le quali gli equipaggi rimanevano in orbita sei mesi, e quelle brevi, finalizzate alla sostituzione della navetta di salvataggio per chi abitava la Stazione spaziale internazionale. Partecipai come ingegnere di bordo a due missioni brevi identificate come taxi flight. Componevamo l’equipaggio in gestione della Soyuz, con il compito di portarla in orbita e riportare a terra quella già in dotazione
“Durante gli 8-10 giorni trascorsi a bordo della Iss per la prima missione, ho anche avuto l’opportunità di effettuare una serie di esperimenti italiani. La terza missione, quella del 2011, fu del tutto diversa: decollai a bordo dello Space Shuttle Endeavour con l’obiettivo di portare in orbita un esperimento denominato Alpha Magnetic Spectrometer, un cacciatore di antimateria, un rivelatore di raggi cosmici dalla tecnologia avanzata realizzato con la partecipazione di 16 nazioni e con un importante contributo italiano.
“In quel caso l’attività principale fu estrarre l’Ams dalla stiva dello shuttle e agganciarlo alla Stazione spaziale internazionale in modo permanente”.
L’Ams durante le fasi di installazione sulla Stazione spaziale internazionale
Ha un ricordo più vivido degli altri?
“Ogni missione è un’esperienza unica. Dalla preparazione al lancio, dalla mancanza di gravità al rientro, passando per le operazioni a bordo, la sequenza di ricordi è indelebile, qualcosa che un astronauta conserva per tutta la vita come un gioiello. Ovvio, la prima volta è irripetibile, ma anche il primo rientro con la Soyuz è difficile da dimenticare.
“Succede tutto con una velocità impressionante: sono 30 minuti in cui una serie di transizioni al limite della sopportazione dell’astronauta e del veicolo è vissuta come un trauma. L’impressione è di essere al culmine delle possibilità sia fisiche che meccaniche, e di non potere controllare alcunché.
Una Soyuz in missione taxi flight nel 2004. Foto Nasa
“Lo Shuttle è una macchina molto diversa dalla Soyuz. Il momento più stressante sulla navetta è il lancio; il rientro è simile, se non più morbido, a un atterraggio con un qualsiasi aeroplano di linea.
“Anche la microgravità è un’esperienza straordinaria. Sono solito descriverla raccontando che, quando si apre un rubinetto, l’acqua non scorre, forma una bolla. Forse è qualcosa cui tutti siamo ormai abituati, avendola guardata decine di volte in video, ma un conto è vederla e un altro è viverla”.
Usando quasi le sue stesse parole, Paolo Nespoli ha raccontato il trauma del suo primo rientro sulla Soyuz. Dice che i russi lo chiamano soft…
“La paura è una condizione legata all’anticipazione di qualcosa. In occasione del mio primo lancio non potevo avere idea di cosa mi aspettasse. La seconda volta lo sapevo bene. Dal momento in cui abbiamo chiuso il portellone per lasciare la Stazione spaziale ed entrare nella Soyuz, aspettavo quella sequenza di eventi: le alte temperature di quando si intercetta l’atmosfera, la fase di frenaggio in cui si passa da 28mila chilometri l’ora a zero, l’apertura del paracadute”.
Ha mai avuto paura durante una missione?
“Certo che ne ho avuta, anche se credo che il concetto di paura sia tutt’altro che univoco. Intendiamoci, in questo momento parla l’uomo, non il professionista: ricordo la preoccupazione di non arrivare al lancio, di non essere all’altezza dei task. L’addestramento è duro e l’ambiente altamente competitivo.
“Poi, quando la partenza è certa, inizia la paura di quello che ti aspetta. È un senso di anticipazione, da un lato, e inquietudine dall’altro. Perché se è vero che andiamo nello spazio da più di cinquant’anni, è altrettanto indiscutibile che un lancio rimane un salto nel buio.
“Pura e semplice, la paura è quella di non tornare a casa“.
Lo space shuttle Columbia si disintegra nei cieli del Texas il primo febbraio 2003
Ha mai vissuto un momento critico, un’emergenza?
“Nella seconda missione, poco prima dello sgancio verso Terra, al test di efficienza la pressurizzazione della tuta Sokol non funzionava.
“Non era un’emergenza, ma un’anomalia, che comunque causa problemi di gestione, perché le tempistiche di volo sono controllate al secondo e bloccarne la sequenza comporta una ripianificazione complessa. Più che per la situazione in sé, il problema era l’inopportunità del momento. Lo stress all’interno dell’equipaggio è stato notevole. Poi, come in un film hollywoodiano, a countdown concluso tutto si è risolto”.
Viste le difficoltà, per quale motivo oggi dobbiamo andare nello Spazio?
“Penso ai satelliti, alle comunicazioni e sono portato a considerare lo Spazio un ambiente di lavoro normale per l’uomo. La risposta, però, è più complessa e la do da padre più che da astronauta: è solo questione di tempo, poi il riscaldamento globale altererà in modo irreversibile l’ecosistema terrestre. L’unico modo per evitarne le conseguenze non è limitare le nostre attività, ma portarle fuori dall’atmosfera. Considero la Luna, Marte e gli asteroidi un’opportunità per evolvere la ricerca scientifica, medica e tecnologica. Soprattutto, però, sono la salvezza per il nostro pianeta“.
Arriveremo su Marte negli anni ’30?
“Non c’è un motivo per cui oggi sia più ragionevole essere ottimisti o no. In questo momento abbiamo una serie di settori tecnologici maturi. Qual è il problema, allora? Percorrere i primi 100 chilometri, cioè uscire dell’atmosfera terrestre.
“Vero, l’abbiamo fatto ripetutamente, ma sfruttando soluzioni costose e ad alto rischio: il tragico incidente dello SpaceShipTwo, nell’ottobre 2014, e l’esplosione, lo scorso settembre, del Falcon 9 su una rampa di lancio del Kennedy Space Center ricordano che sebbene da 60 anni spediamo razzi nello Spazio, la cosa non è semplice, né economica, né sicura“.
I rottami dello SpaceShipTwo poco dopo l’incidente del 31 ottobre 2014
Che cosa intende?
“Che se dovessi scommettere sul prossimo passo dell’esplorazione spaziale, non punterei sulla Luna, ma nemmeno su Marte; scommetterei sui sistemi in grado di superare la tecnologia legata agli attuali razzi.
“Oggi andare nello Spazio è come prendere la macchina e raggiungere la destinazione soltanto col sedile. Funziona, ma non è un modo efficiente di viaggiare. Eppure, quando voliamo fuori dall’atmosfera, saliamo su un razzo e per percorrere i primi 200 chilometri impieghiamo il 90% delle risorse a disposizione.
“Il giorno in cui la tecnologia permetterà di accedere allo Spazio in modo diverso, magari passando al concetto di spazioplano, si aprirà un ventaglio di opportunità nuove per l’esplorazione extraterrestre. Finalmente si intravede qualche alternativa”.
Sta dicendo che ci sono novità?
“Dico che la rotta è tracciata da iniziative come il memorandum di cooperazione fra Italia e Federal Aviation Administration per la disciplina e lo sviluppo del cosiddetto Commercial Space Trasportation.
“Siglato il 30 giugno scorso con Asi ed Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, l’accordo riguarda le tante iniziative private che in questo momento stanno generando un entusiasmo incredibile per il nostro futuro nello Spazio. Si pensi ai veicoli, dalle architetture e dalle concezioni bizzarre, di Burt Rutan, Jeff Bezos o Elon Musk: si stanno stimolando sinergie attorno a una interpretazione innovativa dei viaggi nel cosmo”.
Concezioni bizzarre?
“In un’accezione positiva: mi riferisco a disegni creativi, a geometrie e architetture ambiziose. Non riuscirei a descrivere diversamente i progetti di Bezos e della sua Blue Origin o quelli di SpaceX, sistemi di lancio in grado di andare nello Spazio, fermarsi e tornare indietro.
“Il dato impressionante dell’azienda di Musk è come in dieci anni abbia riprodotto capacità manifatturiere che le agenzie governative hanno acquisito in decadi. Anche progetti come quelli di Virgin Galactic sono cruciali, nonostante sia convinto che concentrarsi solo sul turismo spaziale sia un limite. Sono sicuro che la loro macchina offra più dell’opportunità di spedire escursionisti nel cosmo. E per quanto il loro non sia certo il primo spazioplano, che a onor del vero fu lo shuttle, la novità sta nei costi: quelli esosi del programma Nasa non lo rendevano compatibile con un utilizzo di massa. Al contrario, il progetto di Virgin Galactic ha quell’aspetto di riusabilità che potrebbe farne davvero una chiave d’accesso economica alla volta celeste”.
Non era proprio la premessa del programma Shuttle?
“Ci sono state versioni diverse, a dire il vero: quella originale prevedeva un costo per lancio di circa sette milioni di dollari. Ma il programma, ufficializzato a inizio anni ’70 e basato sull’idea di riutilizzare parte del sistema, si scontrò con i tempi lunghissimi per prepararlo e il relativo aumento dei costi. Così alti che nemmeno la Nasa seppe gestirli”.
Nelle sue memorie sul disastro del Challenger, il premio Nobel Richard Feynman scrisse che ogni lancio dello Shuttle era paragonabile a una roulette russa, tanto alti erano i rischi.
“È brutale, ma i conti sono semplici: su 135 missioni, 2 sono fallite nel modo peggiore, con la perdita degli equipaggi: dal punto di vista probabilistico sono cifre spaventose”.
Ci sarà una quarta volta per lei?
“Spero di sì, specie se nella forma di cui parlavo prima: più che una missione a bordo della Stazione spaziale internazionale, da pilota collaudatore mi piacerebbe essere protagonista di questo nuovo settore sperimentale, quello degli spazioplani”.
Il suo ruolo adesso qual è?
“Sono addetto alle questioni spaziali all’ambasciata di Washington. In questo momento i rapporti fra Italia e Stati Uniti in ambito spaziale sono considerati strategici; ne seguo il lato istituzionale e quanto concerne gli interessi e le relazioni industriali”.
“Se esistono intelligenze extraterrestri, perché non le abbiamo mai viste?“: che cosa risponderebbe al celebre paradosso di Enrico Fermi?
“Che siamo esseri tridimensionali, quadrimensionali se consideriamo il tempo; la probabilità che altri esseri siano come noi, secondo me è bassa. Per conseguenza considero alta l’eventualità che esistano universi paralleli di cui non possiamo avere percezione”.
Quindi esclude esista una tesi ragionevole in grado di negare l’esistenza di un’intelligenza, o anche solo di una vita diverse da quelle terrestri?
“Ritengo improbabile che non ci siano altre forme di vita intelligenti nell’Universo. Potremmo non riuscire a interagirci solo perché su frequenze diverse. È come essere in una stanza chiusa e accanto a un’altra, a sua volta abitata; a meno che gli ambienti non siano comunicanti, non c’è modo di sapere chi ci sia nell’altro locale. Né se ci sia qualcuno.
“Come detto, siamo essere tri o quadrimensionali; potremmo convivere con una forma di vita diversa da noi da questo punto di vista senza alcuna possibilità di interagirci, o comunque con interazioni non in grado di fornire conferma scientifica della coesistenza”.
Quali sarebbero le conseguenze di un’eventuale conferma che non siamo soli?
“Riflettendo su questi argomenti è facile mescolare filosofia e fantascienza. Non mi tiro indietro, ma rispondo a titolo personale, non a fronte del mio ruolo: mi farebbe molto piacere scoprire che non siamo soli.
“Una delle convinzioni che ho sempre avuto è che l’Universo sia un paradosso. Se si ci sofferma sul numero infinito di galassie e pianeti, è difficile scovarne e comprenderne un senso. Ci dev’essere un motivo per cui noi esseri tridimensionali ci perdiamo all’interno di una realtà che probabilmente si esprime anche in altre dimensioni.
“Bene, se ci fosse qualcun altro oltre a noi, gli chiederei aiuto per capire il paradosso della dimensione infinita del nostro Universo. Il che alla fine coincide con il porsi due domande note: chi siamo e da dove veniamo“.
Crede in dio?
“La domanda è logica, ma la risposta non può esserlo. Sono convinto la religione non sia il risultato di un ragionamento: è un istinto, qualcosa che si sente, si percepisce o no.
“Qualche anno fa, a Milano, mi chiesero la stessa cosa durante un incontro con il cardinale Gianfranco Ravasi. Eravamo entrambi ospiti in un dibattito sul rapporto fra fede e scienza. Ricordo che, mentre aspettavo di prendere parola, il cardinale commentava la Genesi. Proseguendo con la lettura mi sembrava via via più evidente la correlazione con cose che avevo visto in orbita, a bordo della Stazione spaziale internazionale”.
Che cosa intende?
“Nei primi tre versi della Genesi, le parole sono usate in un modo molto particolare. Quando si dice che ‘Dio vide che era cosa giusta‘, ricordo Ravasi spiegare che in ebraico la stessa parola tradotta con giusta significa anche bella. La bellezza è la prima cosa da cui si è colpiti, direi invasi, nello Spazio.
“‘E fu giorno e fu notte’, proseguono le scritture: mi sembra una descrizione della sequenzialità del tempo molto poco terrestre. Almeno, non è quella che userei io se mi immaginassi seduto a guardare il cielo. Ma a bordo della Iss, giorno e notte si alternano davvero ogni 90 minuti.
“Quella formula biblica cristallizza perfettamente l’impressione che mi porto dietro da quando ho visto la Terra dalla Stazione spaziale. E mi dispiace non essere più preciso, ma cominciano a essere passati troppi anni”.
Invece è molto chiaro.
“Un altro brano che ricordo è quello che menziona la transizione fra tenebre e luce. Anche in questo caso, se mi immaginassi seduto da qualche parte sulla Terra a descriverlo, non potrei in alcun modo percepire con chiarezza quel passaggio, men che meno scorgerei una linea di demarcazione. Una linea, invece, ben distinguibile dalla Iss.
“Per non dire di quando si parla di ‘galleggiare sull’abisso, nero‘. È l’esatta sensazione che dalla Stazione si ha osservando l’esterno, soprattutto quando si sorvola l’oceano e lo si guarda dalla Cupola, la meravigliosa finestra tridimensionale realizzata a Torino.
“Di tante sensazioni provate in orbita ho trovato nel libro della Genesi la descrizione perfetta“.
La Cupola della Stazione Spaziale Internazionale
Un’immagine di grande fascino, sebbene sia costretto a farle notare che non ha risposto: crede in dio?
“In realtà non c’è risposta. Sono questioni molto personali e – ripeto – in quest’ambito non credo affatto alla logica, ma all’istinto”.
Tornerei allora su questioni meno elevate: fu il presidente Dwight Eisenhower a dare prima una connotazione civile alla Nasa e poi a cambiarne le disposizioni per il reclutamento degli astronauti, ammettendo anche profili non militari. In Italia, generale, si tende ancora a preferire professionalità militari. Perché?
“Qual è la formula magica per scegliere un astronauta? Non esiste. A dire il vero, astronauta è un nome che mi convince poco, è troppo generico. E men che meno in grado di descrivere quello che si fa in orbita.
“Secondo la definizione, io sarei un navigatore degli astri. Ma quali? Mi sono allontanato a malapena di 400 chilometri. Se un alieno arrivato da un altro sistema solare vedesse un oggetto a 400 chilometri dalla Terra, non credo lo considererebbe nemmeno un corpo a sé stante.
“Diciamo allora più semplicemente, e a prescindere dai termini, che il volo nello Spazio è l’estensione di quello aeronautico. In mancanza di idee migliori, siamo partiti dall’analogia per orientarci: in fondo un razzo non è altro che un aeroplano senza ali sistemato in verticale e non è un caso che Yuri Gagarin e Alan Shepard fossero aviatori.
“A un certo punto, soprattutto con l’arrivo della Mir e della Iss, ci siamo resi conto di quanto la vita in orbita avesse più similitudini con quella di un marinaio, comunque un’altra professionalità militare. Credo che presto capiremo come nel futuro sarà sempre più opportuna la figura di un ricercatore, di uno scienziato, piuttosto che quella di un pilota o un marinaio”.
Sembra che la direzione sia quella.
“La Stazione spaziale internazionale ha fatto il suo tempo. Vero, è stupenda e continua a essere un laboratorio dall’importanza unica, però non siamo agli inizi del programma e nemmeno nella sua fase di orientamento. Sebbene non escluda che l’operatività della Iss possa essere prolungata oltre il 2024 [a oggi l’anno fissato per la sua dismissione, nda], sarebbe il caso di ricordare la sua data di nascita: 1998″.
Lei ha contribuito alla sua costruzione.
“Diciamo che l’ho vista crescere: nel 2002 quando c’erano tre moduli, poi nel 2005, quindi nel 2011 quando è stata completata. È diventata grande. Letteralmente”.
C’è un film, o un libro di tematica scientifica o spaziale, che abbia avuto un ruolo decisivo nella sua vita?
“Fra i tanti, sì, si intitola Orion. È un romanzo di Ben Bova e descrive un approccio allo spazio che non c’è stato. Fa capire come alcune delle domande poste correttamente in questa intervista avrebbero avuto un’impostazione radicalmente diversa se in passato l’uomo avesse fatto altre scelte. Spiega il motivo per cui oggi siamo ancora così vicini alla nostra culla e non oltre il Sistema solare”.


Nello Spazio, qual è la sfida più grande da vincere per l’uomo?
“Per migliorare o accelerare la nostra capacità di sfruttare le risorse extra atmosferiche, dobbiamo lavorare sulla transizione nei primi 100 chilometri del lancio, quell’iniziale corridoio aperto sul cosmo.
“Occorre passare dalla concezione tradizionale di razzo a quella di spazioplano, un velivolo in grado di abbandonare l’atmosfera e poi rientrarci. Considero ogni altro passo conseguente a questo. Non ne va solo delle esplorazioni spaziali. È il nostro futuro a essere coinvolto”.
Il droide incontrato da Wall-e sulla Axiom non avrebbe saputo dirlo meglio.


Vuoi ricevere aggiornamenti su questo argomento?