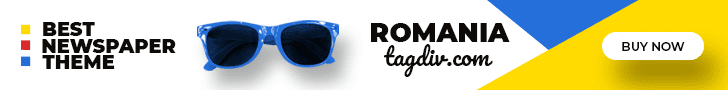Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Fine anni Venti del Novecento. La Prima guerra mondiale è alle spalle e mentre i soldati americani tornano in patria, la comunità Osage da anni in Oklahoma ha scoperto il petrolio ed è diventata ricchissima. I suoi pozzi sono su territorio indiano, non federale, quindi non americano, eppure la lunga mano degli americani cerca di arrivare a loro e a quello che hanno. Innanzitutto a livello statale, tenendo sotto controllo le spese dei nativi e sfruttando il più possibile i loro soldi. Parallelamente si verificano diversi omicidi di alcuni Osage, soprattutto tra quelli appartenenti a una facoltosa famiglia indiana. A vegliare sulla comunità, c’è William Hale, formalmente proprietario terriero e imprenditore agricolo, ramo allevamento, il cui obiettivo, però, è ottenere i soldi degli Osage. Quando suo nipote Ernest Burkhart torna dall’Europa a guerra finita, il vecchio Hale lo manipola prima facendolo sposare con una giovane Osage, Mollie, e poi convincendolo a penetrare nella fortuna economica della moglie. I morti Osage diventano sempre più frequenti, e intanto l’FBI arriva nella ricca comunità, portando l’idea di diritto e giustizia.
Precisiamo subito: Killers of the Flower Moon non è un film diretto da Martin Scorsese come ci si aspetta che debba essere. Non c’è, infatti, la spettacolarizzazione della trama, non ci sono momenti di maggiore intensità narrativa a creare la suspense, non ci sono i bassifondi e i reietti che spuntano fuori dalla melma con il loro muso, né la malavita che cerca di ottenere il potere, non c’è nemmeno la riflessione ultra concettuale su alcune macroquestioni del mondo, come il senso della vita o la redenzione dell’esistenza, come le sceneggiature scritte da Paul Schrader hanno descritto. Non c’è niente di tutto, ma forse c’è tutto questo. Bisogna subito dire che il film è estremamente lento. Anche se ha un minutaggio importante, non ha il ritmo delle epopee criminali narrate da Scorsese, ma questo nuovo film si incardina in una lenta acquisizione di pezzi che compongono il puzzle finale. Il momento iniziale è, infatti, molto chiaro, presenta la situazione, ai limiti del didascalico. L’intrecciarsi della presentazione della famiglia del vecchio William Hale (interpretato da un Robert De Niro rinsecchito e arcigno, piccolo di statura e incastrato nella sua avidità) e le grandi inquadrature aeree, i suoni di strumenti tipici degli indiani d’America e la declamazione dei loro riti, spiegano la situazione iniziale. Poi arriva sulla scena Ernest Burkhart, ruolo ricoperto da Leonardo Di Caprio, che si insinua nella famiglia di Mollie Burkart (Lily Gladstone, maschera perfetta che cambia a seconda di come si evolve il film) e segue le indicazioni del grande burattinaio. Da questo momento in poi, circa un’ora di film è passata, e la narrazione frena drasticamente. Già prima non era stata particolarmente vivace, come detto, ma ora si congela e segue le note del blues, della musica lenta dell’anima e dei suoi patimenti, che scorrono in un sottofondo appena udibile, ma presente. In questa parte del film, le riprese aree atterrano, la macchina da presa si muove poco, se non fosse per qualche piano sequenza alla Scorsese in cui è inquadrato un interno in cui si stringono tutti i personaggi, per poi soffermarsi sui volti. Soprattutto sono ricercati dal regista i volti di Hale e Burkhart. Il primo con il ghigno severo tipico dell’attore americano, il secondo con lo sguardo basso e rinchiuso nel suo prognatismo; insieme stabiliscono quell’asse di avidità e servitù, volontà di potere e autodistruzione morale e umana del secondo su cui si orchestra la parte centrale del film. Hale è un grande burattinaio che sancisce chi deve vivere e deve morire, mentre il nipote Ernest è il braccio armato che, in realtà, non commettete nessun omicidio, ma istruisce chi deve uccidere chi. Tra loro si muove Mollie che quando perde la sua famiglia (bellissima la scena della morte della madre della ragazza che Scorsese ricrea seguendo quella che può sembrare come l’idea di morte degli indiani d’America, ossia essere accompagnati nell’aldilà dagli spiriti di famigliari), decide con gli altri Osage di andare a Washington e parlare con il Presidente degli Stati Uniti, anzi di pagare una somma perché lui invii degli agenti a investigare tutte queste morti, dal momento che la polizia non fa nulla, elemento questo segnalato già all’inizio del film. Questa parte, la parte centrale, è descritta scandendo scena dopo scena la vicenda; non c’è voglia da parte di Scorsese di stupire, ma di permettere a chi osserva di mettere insieme i pezzi. Alla fine lo spettatore si rende conto che non è successo un granché e che i tasselli da unire sono pochi, eppure proprio questa dilatazione dei fatti narrati crea quasi un senso di epico, di racconto fiume. Si arriva, così, allo spannung, al momento di maggiore tensione che non esplode, ma si presenta come la normale e logica conseguenza degli eventi. Non c’è la ricerca dell’effetto drammatico, ma tutto sembra congelato, proprio come gli agghiaccianti delitti di cui si compone il film. Capite, quindi, perché è uno Scorsese non Scorsese? Il film comunque propone alcuni caratteri del suo cinema come l’idea dell’autodistruzione del protagonista che si crede forte e deciso, salvo poi ricredersi quando di fronte a lui si palesa la realtà dei fatti. E la sua redenzione finale? C’è e avviene come un effetto naturalmente conseguente a quanto finora fatto; forse questa parte del film appare un pochino prevedibile, anche se è intrigante narrativamente l’aggancio con cui avviene. La scena finale, poi, è introdotta dalla voce che dice: «A vincere è il diritto!» ed effettivamente questo trionfa, tanto quanto il senso di giustizia e di legalità. Questa scena, poi, è una chicca e un tributo alle storie narrate alla radio in quell’epoca. Un vero gioiellino di cinema.
Quindi, Killers of the Flower Moon possiamo dire che è diretto da uno Scorsese crepuscolare e probabilmente stanco. Se vi ricordate la scena finale di The Irishman e quel piano sequenza all’indietro, ecco quest’ultimo film ne è la netta conseguenza. Un film che non vuole stupire, non vuole far innamorare il pubblico del protagonista della storia o del personaggio e sembra quasi sfilarsi dal cinema di oggi, soprattutto dal grandissimo impatto visivo dei film prodotti dall’asse Hollywood-Marvel che il regista americano ha più volte criticato. In fondo, comunque rimane il graffio di Scorsese delle sue aperte polemiche contro gli Stati Uniti e le sue manchevolezze statali che creano emarginazione e disparità. Se gli Osage non avessero pagato per aprire l’inchiesta dell’FBI, questo sarebbe mai arrivato in quelle terre? Questo è quello che si domanda il film. Poi c’è la brama di potere, forte e nel DNA degli americani che si allarga ai nativi, per quanto questi si rendano conto della corruzione morale perpetrata dall’uomo bianco (e diciamo che questa linea narrativa poteva essere più approfondita ed è solo accennata). Killers of the Flower Moon non è un film perfetto, ha molti problemi soprattutto narrativi e anche di inquadrature, troppo spesso Scorsese si attesta su una non volontà di muovere la macchina in modo tale da portare lo spettatore a vedere altro, ma, alla fine, è pur sempre un film di Scorsese. Il regista sembra conscio di aver fatto il suo tempo e quell’allontanarsi da terra con la macchina da presa nella scena finale, ne è il chiaro simbolo, eppure vuole fare cinema, perché per fortuna sa ancora farlo.