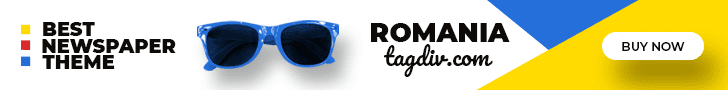Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
È pur vero che, in fondo – l’ultima, proprio di recente, YouTube – le piattaforme questo lavoro di protezione interna lo fanno da anni. E allora a Rodriguez si potrebbe anzitutto contestare che evidentemente gli strumenti di parental control non bastano. Oppure che ai genitori spetti un salto in avanti culturale, educativo e di consapevolezza che li guidi a usarli davvero e con efficacia. Ma il mestiere di genitore è il più difficile del mondo e non mi sentirei di mettere sotto accusa qualche miliardo di esseri umani. O forse si potrebbe addirittura replicare che quegli strumenti di parental control sono solo un modo delle piattaforme per lavarsi le mani rispetto a controlli sull’età – quelle età minime che già fanno parte delle loro condizioni d’uso e si allineano alla legislazione statunitense ed europea – che in fondo potrebbero implementare più efficacemente anche senza avere il documento?
Crescere un mercato
In altre parole, la questione posta dalla ricercatrice – pur partendo dal presupposto comune che richiedere i documenti sia una distrazione politica – si potrebbe anche ribaltare. Da anni in chi studia approfonditamente il settore balena infatti il dubbio, se non la convinzione, che colossi come Meta, Bytedance o Alphabet investano sulla sicurezza dei bambini certamente in virtù degli obblighi di legge, di quelli per così dire “morali” e per evitare una serie di conseguenze di vario tipo, almeno a livello formale, ma anche per un’altra ragione. Più di medio-lungo periodo: quella di crescersi sostanzialmente in casa, con i vari strumenti di controllo genitoriale per i minori di 13/14 anni o addirittura con le piattaforme su misura per i bambini, gli utenti del prossimo futuro. Mini utenti abituati già in tenera età a grammatiche, funzionalità e logiche delle piattaforme, anche se zuccherate, limitate e colorate.
E allora, se proprio bisogna costruire un vero internet dei bambini, emerge semmai un’altra riflessione: bisognerebbe fare tabula rasa. Perché queste piattaforme non “mollano” definitivamente i pre-teen e magari anche i minori? Perché, cioè, non spostano il focus, i modelli di business, l’attenzione e le pressioni su altri target e altri pubblici invece di coltivarsi con ostinata pervicacia – magari anche con strumenti utili, nessuno lo nega – l’audience del prossimo futuro?
Insomma, siamo sicuri che quelli che hanno partorito una rete così tossica per i più giovani e sono poi tornati in tutta fretta di problematica in problematica a mettere qualche toppa con la coda fra le gambe e con qualche inchiesta governativa sul collo siano gli stessi a cui possiamo affidare il compito e la responsabilità di costruire degli ambienti digitali ideali e su misura per i più piccoli? Se c’è da costruire questa internet dei bambini, allora dovrebbe emergere da un’alleanza pubblico-privata scientificamente accompagnata. Non da un impegno governativo esclusivo, come dice Rodriguez, né tantomeno da proposte unilaterali introdotte a ritmo sincopato dalle stesse società che negli anni hanno reso i genitori, di quei bambini, dipendenti dalle loro piattaforme.