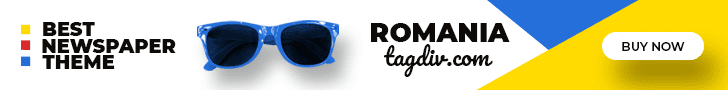Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Venkatraman Ramakrishnan, l’uomo della morte. Nonostante non sembri una buona presentazione, di fatto lo è: Ramakrishnan è difatti uno dei più eminenti scienziati al mondo nel campo della biologia strutturale e, collateralmente, nel campo dei processi cellulari legati all’invecchiamento e, per l’appunto, alla morte. È stato insignito del premio Nobel per la chimica nel 2009 per la sua scoperta della struttura del ribosoma, una cruciale “macchina” cellulare responsabile dell’espressione dei geni. Oltre che ricercatore di primo piano, Ramakrishnan è anche un prolifico autore e divulgatore: dopo l’enorme successo de La macchina del gene, un memoir in cui racconta il suo viaggio umano e scientifico, ha pubblicato il poderoso Why we die, un saggio – come suggerisce il nome – dedicato per l’appunto a illustrare le dinamiche che regolano l’invecchiamento e che, progressivamente e inesorabilmente, portano alla morte. Venkatraman Ramakrishnan è stato recentemente in Italia, a Milano, dove ha tenuto una lectio magistralis in occasione della seconda edizione del Milan Longevity Summit, il più importante appuntamento italiano dedicato alla longevità e al benessere psicofisico organizzato da BrainCircle Italia. È stata l’occasione per incontrarlo e fargli qualche domanda.
Professor Venkatraman Ramakrishnan, la domanda cruciale del suo libro è perché moriamo. Ma, esattamente, cos’è la morte?
Per morte intendiamo la perdita irreversibile della capacità di funzionare come un individuo coerente. È il risultato del fallimento di un sistema o apparato critico, ad esempio insufficienza cardiaca, cerebrale, polmonare o renale. In questo senso c’è un apparente paradosso: quando il nostro organismo, nella sua interezza, è vivo, milioni di cellule dentro di noi muoiono costantemente, e non ce ne rendiamo nemmeno conto. D’altra parte, al momento della morte, la maggior parte delle cellule nel nostro corpo sono ancora vive e interi organi sono ancora funzionanti e possono essere donati a persone che necessitano di trapianto. Ma a quel punto il corpo ha perso la capacità di funzionare nel suo complesso. In questo senso è quindi importante distinguere tra morte cellulare e morte dell’individuo.
Parlando di morte e invecchiamento, nel libro afferma di “voler offrire uno sguardo obiettivo sulla nostra attuale comprensione dei due fenomeni”. Qual è stata la sorpresa più grande o la convinzione più radicata che ha dovuto riconsiderare durante la scrittura e la ricerca?