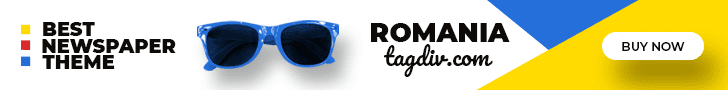Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
La storia del Conclave nei secoli. Dall’extra omnes all’habemus papam, la ritualità dell’elezione di un pontefice è entrata nel nostro linguaggio, amplificata negli ultimi decenni dai mezzi di comunicazione che ci hanno regalato le immagini di un comignolo fumante nuvole bianche o nere a seconda dell’esito della votazione. Una ritualità che sembra, come tante cose nella Chiesa Cattolica, immutata nel tempo, ma che non è sempre stata così. A cominciare dal nome: conclave, dal latino cum clave, a suggerire porte chiuse a chiave. L’espressione indica tanto il luogo fisico della riunione, quanto la riunione stessa dei cardinali chiamati a eleggere un nuovo papa. Il primo conclave propriamente detto si è svolto nel 1271 a Viterbo. Ma non è certo questa la data della prima elezione pontificia.
I successori di Pietro
Il primo papa, o per meglio dire il primo capo della cristianità dopo la morte di Gesù di Nazaret, fu secondo la tradizione cattolica Pietro, quel Cefa su cui i Vangeli raccontano che Cristo avrebbe fondato la sua Chiesa. Il suo successore fu Lino, indicato dallo stesso Pietro all’assemblea dei Cristiani di Roma: siamo nella seconda metà del primo secolo d.C e per molti decenni l’elezione del capo della Chiesa fu affidata al popolo dei credenti dell’Urbe. Dopo l’Editto di Costantino, che nel 313 d.C. consentì lo sviluppo della nuova religione alla luce del sole, la scelta del Papa fu affidata al clero romano. Niente votazioni, però: si procedeva per acclamazione, in seguito alla quale il Vescovo di Roma veniva presentato ai maggiorenti della città, che potevano disapprovare la scelta. Di qui tanti episodi di incertezza, lungaggini, e il sorgere di antipapi. L’imperatore Giustiniano nel VI secolo addirittura subordinò la scelta del Papa all’approvazione imperiale. Una situazione che durò oltre la caduta dell’Impero Romano di Occidente, fino al 731, con Gregorio III che si oppose alle ingerenze della corte di Costantinopoli. Si torna quindi alla situazione precedente, con il papa eletto dai sacerdoti e dalle famiglie romane, ma con una pressione sempre maggiore da parte delle diverse fazioni di potere. Fu Nicola II nel 1059 ad affidare l’elezione ai soli cardinali vescovi, mentre nel 1179 Alessandro III la estese a tutti i cardinali, rendendo necessari i due terzi dei voti per la decisione. E se a eleggere dovevano essere le alte sfere del clero, l’eletto poteva essere un tizio qualsiasi, purché battezzato.
La storia del primo conclave
Il documento di istituzione formale del conclave risale al 1274, con il secondo Concilio di Lione: Gregorio X presentò la costituzione apostolica Ubi periculum, che riformava i meccanismi di elezione dopo il lungo periodo di “vacanza” seguito alla morte di Clemente IV. Era infatti successo che per 33 mesi diciannove cardinali riuniti a Viterbo non erano stati in grado di scegliere un nome: nei primi tempi i prelati si incontravano quotidianamente nella cattedrale (era tradizione che l’elezione si svolgesse nella cattedrale della città in cui il papa era morto), per poi tornare la sera ciascuno alla propria dimora. Ma le traversie si succedevano e i tempi si allungavano a dismisura; il popolo diventava insofferente e le autorità locali decisero di agire. Chiuse le porte della città, costrinsero i cardinali a entrare nel Palazzo dei papi, dove li rinchiusero, comunicando loro che non sarebbero usciti se non a elezione avvenuta. Aggiunsero, per maggior sicurezza, una riduzione nel regime alimentare. Inoltre il tetto venne scoperchiato, perché lo Spirito Santo potesse (testualmente) scendere più facilmente a guidare i sacerdoti. Per evitare il sorgere di situazioni simili, la costituzione del 1274 stabiliva una serie di rigidi protocolli: i cardinali dovevano rimanere nella città in cui era morto il pontefice e attendere gli assenti per dieci giorni; dopo di che si sarebbero riuniti nel palazzo dove il papa aveva abitato, con un seguito ridotto all’essenziale, ossia un servitore ciascuno; avrebbero dovuto abitare «in comune una sola sala, senza pareti intermedie o altro tendaggio (…) chiusa da ogni parte affinché nessuno possa entrare o uscire da essa». Se entro tre giorni i cardinali non avessero deciso, sarebbero stati messi a dieta stretta, con un solo piatto a pranzo e a cena servito attraverso l’unica finestra aperta sull’esterno. Se ancora il verdetto tardava, si sarebbe passati a un regime da fame, solo pane, vino e acqua. E nessuna retribuzione per tutto il periodo del conclave. Chi trasgrediva incorreva nella scomunica. Tali restrizioni vennero confermate in seguito, nonostante le proteste dei porporati, da Celestino V e Bonifacio VIII.
Saccheggi e simonia, tumulti di popolo e lotte di potere
Cambiano dunque modalità e riti, ma una costante rimane nei secoli, fin dai primi anni della Chiesa: spoliazioni e saccheggi accompagnarono in più occasioni il passaggio da un papa all’altro, eventi testimoniati fino dal V secolo e riportati dagli storici nelle epoche successive. A essere razziati potevano essere i beni del defunto pontefice o quelli del neoeletto: una sorta di tradizione violenta che rientrava in quel quadro di lotte e contrapposizioni tra fazioni diverse durato per lunghissimo tempo. A razziare erano soldati, chierici e popolani, e addirittura altri vescovi: nel 1378 il cardinale Corsini di Firenze rubò un reliquiario del defunto papa Gregorio XI, ma lo dovette restituire. Il saccheggio era sì una condotta biasimevole, ma accettata in considerazione dello straordinario impatto dell’evento. Moti di protesta potevano essere suscitati da un’opposizione alle politiche del papa eletto ma anche alle sue origini: il popolo non amava gli stranieri, e non desiderava che salissero al soglio pontificio, quasi fossero degli usurpatori. Un altro vizio endemico nelle elezioni papali fu per lungo tempo la simonia, legata non solo a interessi economici dei diversi potentati ma anche ad accordi politici e, nei secoli più recenti, all’ingerenza degli stati europei.
Nuove regole per un nuovo pensiero
Per porre un freno alla ridda di mali che si accompagnavano al conclave, Gregorio XV emanò tra il 1620 e il 1621 due bolle che ribadivano le regole della clausura e aggiungevano precise disposizioni sui tempi e sulla procedura da seguire durante le votazioni: i cardinali potevano eleggere il pontefice per ispirazione o acclamazione all’unanimità, oppure per compromesso in seguito a un accordo tra gruppi diversi, o con votazioni a schede, con una maggioranza di due terzi. Il voto doveva essere segreto, tanto che divenne necessario bruciare le schede: era nata l’usanza della fumata bianca per indicare l’avvenuta elezione o nera in caso di fallimento. Questa normativa rimase sostanzialmente immutata fino ad oggi. L’ingerenza del potere temporale venne combattuta a lungo, e solo nel 1904 Pio X abolì il diritto di veto che ancora avevano le potenze cattoliche. Insieme al cerimoniale a partire dall’età moderna si andò consolidando la definizione del luogo del conclave: Roma, e più precisamente, a partire dalla sua costruzione, la Cappella Sistina. Il primo papa qui eletto fu Leone X nel 1513, poi la cappella venne saltuariamente utilizzata e a partire dal 1878 è diventata la sede stabile.
Poche altre modifiche hanno cambiato la procedura in tempi recenti: Paolo VI ha introdotto il limite di 80 anni per i cardinali elettori. Giovanni Paolo II ha abolito l’elezione per acclamazione o per compromesso. Benedetto XVI ha modificato le regole relative alla maggioranza, rendendole ancora più restrittive, e ha stabilito la scomunica per chi violi il segreto sull’andamento dei lavori.