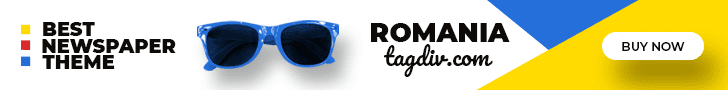Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Il villaggio dei dannati di John Carpenter usciva in sala esattamente 30 anni fa, il 28 aprile 1995. Ancora oggi, si tratta di uno dei film più sottovalutati del grande regista americano, in virtù della sua natura di remake, ed anche del tono sicuramente diverso dai suoi lavori più noti. Eppure, a guardarlo meglio, per tematiche e significati, questo sci-fi horror è tutto tranne che trascurabile.
Un remake capace di camminare sulle proprie gambe
Il villaggio dei dannati nasce in modo per certi versi strano o almeno così potrebbe sembrare a primo impatto. Il Maestro dell’horror ha firmato con la Universal un contratto un po’ capestro in un certo senso, è successo al tempo in cui si era fatto un nome e coglieva successi di critica e pubblico. Quattro film, ma l’accordo è ormai per lui una gabbia, lo è forse anche per la Universal, ma pochi si aspettano da lui un remake del classico del 1960 di Wolf Rilla, tratto dal romanzo di John Wyndham. Pochi a parte lui ovviamente. Era stato sicuramente un grande successo a suo tempo, di critica e pubblico. Carpenter ha visto quel film da dodicenne, gli si è conficcato nella memoria per non uscirne più, come spesso capita a quell’età e allora dà sostanzialmente licenza allo sceneggiatore David Himmelstein di esservi fedele.
Himmelstein rimarrà farà ciò che gli viene chiesto. Ci penserà Carpenter a cambiare il finale, altro elemento che lo rende il suo ultimo, vero, grande atto creativo sul grande schermo. Film sicuramente atipico, Il villaggio dei dannati è meno violento, meno irruento e visivo rispetto a La Cosa o Halloween o Essi Vivono. Ma non è certamente quel passo falso, quell’opera superficiale, come all’epoca molti la definiranno. Anzi. A trent’anni esatti di distanza dal suo debutto in sala, di quel 28 aprile 1995, questo film ci appare come semplicemente diverso per stile e natura, ma incredibilmente attuale e “carpentariano” per temi e significati, per l’intelligenza con cui Carpenter si ricollega (non solo nella location californiana) al suo Fog, a quella piccola città che pare uno specchio dell’America.
Midwich, piccola città portuale, di quelle dove tutti sanno tutto di tutti. Durante una sorta di festa cittadina, tutti gli abitanti svengono. Quando riprendono i sensi, scoprono che una decina di donne sono incinte. Ma di chi? Come è successo? Quando vengono al mondo, i bambini sono tali solo in apparenza. Si muovono a coppie, hanno pelle e capelli bianchi, una mente già adulta e poteri telepatici immensi, gli occhi diventano tizzoni ardenti quando ne fanno uso. Succede quando si sentono minacciati od ostacolati e chiunque si metta in mezzo viene ucciso per indotto suicidio. Sono spietati. Solo il piccolo David (Thomas Dekker), che ha perso la sua “compagna” alla nascita, appare empatico, sensibile, privo della spietatezza degli altri, venendone quindi emarginato. Mara (Lindsey Huan) del gruppo dei bambini è la più spietata, la più energica.
Figlia del medico Alan Chafee (Christopher Reeve), ha costretto la madre a suicidarsi, e si dimostrerà la leader di quel gruppo. Il villaggio dei dannati ci mostra un mondo in preda ad una vera invasione, le stesse Forze Armate sono incapaci di fermare quei piccoli esseri diabolici, lo stesso dicasi per le preghiere di Padre George (Mark Hamill). John Carpenter, ricalca il film originale, ma poi se ne stacca e ci guida verso un percorso in cui il concetto di individualismo e quello di solitudine si compenetrano. C’è un tono apocalittico chiaro, lineare e coerente che attraversa tutto il film, di base un racconto sull’impotenza, sull’umanità che cerca di fermare la parte più spietata e fredda di sé stessa. Non valgono a molto gli sforzi della scienziata, la Dott.ssa Susan Verner (Kirstie Allen), la soluzione arriverà dall’amore di Jill (Linda Kozlowski), madre di David, il vero asse attorno a cui ruota tutta la vicenda.
Un racconto sulla nascita dell’individualismo postmoderno
Carpenter, autore anche della colonna sonora assieme a Dave Davies, opta per un’atmosfera in cui la sensazione di oppressione, di inquietudine costante, viene via via aumentata dagli improvvisi scoppi di violenza, dalla crudeltà che quei piccoli esseri somministrano agli adulti che cercano di fermarli o ragionarci. Quei bambini altro non sono che il simbolo del rifiuto impellente nell’Occidente del concetto di comunità, di altruismo. Il Muro di Berlino è caduto, l’URSS è finito, la Terza Via impera, si pone come obiettivo di creare una mediazione tra il neoliberismo e la socialdemocrazia. Ma l’unico risultato, già visibile allora, è quello della comparsa di un egoismo, di un “tutto intorno a te”, che diventerà la porta verso l’isolamento. Solo quattro anni più tardi esce The Matrix, che ci parlerà in termini tecnocratici dello stesso problema.