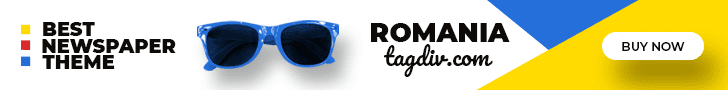Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
L’eloquio è lento, cauto, come se sotto le piante dei piedi le mine antiuomo fossero ancora lì. Tra le mani il metal detector, nelle orecchie il ticchettio. Le sillabe gli escono una a una scandite dalla voce roca, modellata, si intuisce, da tante letture e lunghe meditazioni.
Vito Alfieri Fontana è un uomo che cerca un equilibrio tra due stagioni della vita, entrambe appartenenti al passato, entrambe difficili da dimenticare. Settantacinque anni, produttore di mine antiuomo fino ai primi anni Novanta – settore in cui l’Italia svettava a livello globale – smantellò un’azienda ben avviata, la pugliese Tecnovar, tagliando i ponti con la famiglia poco dopo. Non gli perdonarono di aver affossato un’industria che prosperava, e, con le norme di allora, operava nella legalità, per uno scrupolo di coscienza.
Nei lavori che portarono alla Convenzione di Ottawa, che mise al bando i micidiali ordigni, c’è il suo contributo di profondo conoscitore delle sottigliezze meccaniche di queste armi. Proprio in mezzo allo scetticismo di chi, nelle organizzazioni non governative, era abituato a vederlo dall’altra parte della barricata. Ma la sua conoscenza ingegneristica acquisita al tavolo da disegno contribuì, invece, a impedire di concordare un testo impreciso, buono per la propaganda ma inutile nei fatti. Una formulazione così precisa che ha indotto molti attori statali con interessi nel mercato delle armi a non procedere con la ratifica. Un gruppo nutrito, che comprende Cina, India, Russia, Israele, Cuba, Egitto, Marocco, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Myanmar, Pakistan e Iran. Oltre che gli Stati Uniti che però, in una delle piroette della diplomazia internazionale, finanziano il Landmine Report che fornisce una panoramica globale degli sforzi per universalizzare e attuare pienamente il Trattato sulla messa al bando delle mine antiuomo. Tra i 164 firmatari, invece, ci sono Palestina (unita di recente, nel 2017) e Ucraina, il cui territorio è tempestato dalle mine di Mosca ma che, secondo il rapporto americano, avrebbe a propria volta utilizzato gli ordigni nel conflitto in corso.
Poi, per Fontana, cominciarono diciott’anni nei campi dei Balcani, per bonificarli e restituire la terra alla popolazione civile. E per bonificare anche l’anima, messa in crisi all’improvviso dalle domande ingenue di un figlio, di un prete e di un attivista. Il percorso è raccontato nel libro che Fontana ha scritto con il giornalista di Famiglia Cristiana Antonio Sanfrancesco: Ero l’uomo della guerra, Laterza editore. “Non si tratta di una conversione religiosa”, precisa Sanfrancesco, anche se la fede senz’altro ha sostenuto l’ingegnere pugliese, impedendogli di cedere alla disperazione.
Due dollari per uccidere
Pagine che scorrono, righe che descrivono in maniera asciutta e senza traccia di autoassoluzione l’esaltazione che pervade chi guadagna con le armi. Anche venticinque milioni di lire al mese, una fortuna. “Non pensavo alle conseguenze; il male genera sempre una strana euforia”, ricorda Fontana. La guerra, per chi la finanzia, è un affare da hotel, whisky, belle donne, mazzette di banconote allungate sul tavolo o infilate nella tasca della giacca. Nelle fiere mondiali di settore si trova di tutto, dal fucile a pompa al carro armato, e girano sempre le stesse facce: nomi da chiamare, che sanno come muoversi. E sono, soprattutto, affidabili.