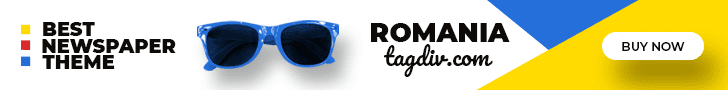Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
La teoria della relatività di Albert Einstein, ovvero “la più sorprendente combinazione di penetrazione filosofica, intuizione fisica e abilità matematica”, come la definì Max Born (non esattamente un signor nessuno). Una straordinaria intuizione che scosse le fondamenta della fisica e riscrisse letteralmente le coordinate dell’Universo, legando tra loro, in modo del tutto inusitato, la geometria dello spazio-tempo e la gravità. A formularla, come dicevamo, fu Albert Einstein, il fisico che oggi, per tutto il mondo, rappresenta per antonomasia la personificazione della scienza e di cui ieri, 18 aprile, ricorreva il settantesimo anniversario della morte. Il suo viso, i suoi baffoni e capelli arruffati, la sua linguaccia, la pipa, la penna infilata nel maglione, la lavagna piena di calcoli, sono immagini praticamente ubique, presenti nell’immaginario collettivo di tutti. Per celebrare la ricorrenza vi riproponiamo il racconto della teoria della relatività, o meglio delle teorie della relatività, perché il genio di Ulm ne formulò due versioni, entrambe rivoluzionarie: una ristretta, o speciale, relativa (sic!) al comportamento dello spazio e del tempo a velocità prossime a quella della luce, e una generale, dedicata per l’appunto alla descrizione della misteriosissima forza di gravità.
Giusto un paio di problemini
Cominciamo dalla versione ristretta. Siamo all’inizio del Novecento e la comunità dei fisici è particolarmente soddisfatta dal sapere accumulato fino a quel momento. Serpeggia l’idea – la presunzione – di aver ormai compreso quasi tutto quello che c’era da comprendere: nei corridoi delle università e attorno ai banchi di laboratorio i fisici si dicevano che, una volta sistemati un paio di problemini ancora irrisolti, la strada sarebbe stata tutta in discesa. Mai previsione fu più sbagliata. Entrambi i problemini si sarebbero rivelati molto più complessi del previsto, e soprattutto la loro soluzione avrebbe spalancato la porta alle due rivoluzioni più importanti della fisica moderna. Il primo, il cosiddetto problema del corpo nero, avrebbe costituito l’innesco per lo sviluppo della meccanica quantistica. Il secondo, il problema della velocità della propagazione della luce, sarebbe stato appunto alla base dello sviluppo della teoria della relatività ristretta. Questo il tema: secondo le equazioni di Maxwell, che descrivono il comportamento delle onde elettromagnetiche, la luce si propaga nel vuoto a una velocità fissa, circa 300mila chilometri al secondo, indipendentemente dalla velocità dell’osservatore; ma la meccanica classica postula che le velocità si sommino o si sottraggano a seconda della velocità dell’osservatore (per esempio: se un treno viaggia a 100 km/h e un altro in senso opposto a 120 km/h, la velocità relativa è 220 km/h).
La teoria della relatività ristretta
Una delle idee proposte per comprendere perché la luce sembrasse comportarsi in modo diverso rispetto ai treni fu il cosiddetto etere, una sorta di “mezzo invisibile” entro il quale la stessa luce si sarebbe propagata, un po’ come il suono si propaga nell’etere. Nulla di fatto: sebbene si cercasse di stanarlo in tutti i modi possibili, con esperimenti molto raffinati, dell’etere non c’era alcuna traccia. La luce, dunque, continuava a muoversi ostinatamente alla stessa velocità senza alcuna apparente spiegazione.
È a questo punto – siamo al 1905 – che entra in scena un giovane impiegato dell’Ufficio Brevetti di Berna, il dottor Einstein, che in un articolo intitolato “Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento” propone una nuova teoria che elimina del tutto il concetto di etere e propone due postulati fondamentali: uno, le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali (cioè quelli che si muovono a velocità costante l’uno rispetto all’altro; vuol dire che se ci si trova su un treno e non si può guardare fuori, non c’è modo di stabilire se il treno si sta muovendo a velocità costante o è fermo); e due, la velocità della luce nel vuoto è la stessa per tutti gli osservatori, indipendentemente dalla velocità della sorgente e dall’osservatore, ed è una velocità limite (ossia niente può muoversi più velocemente della luce). Questi due postulati, che costituiscono, per l’appunto, il cuore della teoria della relatività ristretta, portano a conseguenze bizzarre e straordinarie. La prima è la dilatazione del tempo, un fenomeno diventato poi soggetto di innumerevoli film, libri e paradossi: un orologio in movimento rispetto a un osservatore fermo scorre più lentamente, e le sue lancette si fermano (sempre dal punto di vista dell’osservatore fermo) quando la velocità dell’orologio è quella della luce. La seconda è la famosissima equivalenza tra massa ed energia, riassunta nella celebre formula E=mc2.
La teoria della relatività generale
Dalla luce alla gravità. Ancora una volta, per comprendere la portata di quest’altra intuizione di Einstein dobbiamo fare un passo indietro, e tornare all’epoca della formulazione della legge di gravitazione universale di Isaac Newton, secondo la quale le masse esercitano un’azione attrattiva e istantanea l’una sulle altre, che chiamiamo, per l’appunto, gravità. La relatività ristretta, come abbiamo appena visto, prevede però che niente possa muoversi più velocemente della luce. E questo genera un altro problema: secondo la teoria di Newton, se il Sole scomparisse all’improvviso, la Terra cesserebbe istantaneamente di sentirne l’attrazione gravitazionale; ma la relatività ristretta dice che nessuna informazione può trasmettersi istantaneamente. E quindi?
Albert Einstein intuì come risolvere la questione, elaborando nel 1915 un’equazione di campo che, come anticipato, rivoluzionava completamente il concetto di gravità, legandolo alla geometria dello spazio e del tempo. Secondo tale equazione, che rappresenta il nocciolo teorico della teoria della relatività generale, la forza gravitazionale altro non è che la manifestazione di una nuova entità, lo spazio-tempo, una specie di tessuto a quattro dimensioni, una spaziale e una temporale, di cui è fatto il nostro Universo. La più abusata (ma utile) metafora per comprendere lo scenario descritto da Einstein è quella del foglio di gomma: lo spazio-tempo si può immaginare, per l’appunto, come una superficie morbida che viene curvata dalle masse che vi sono appoggiate sopra (anche se la metafora non è del tutto precisa dal punto di vista scientifico, rende abbastanza bene l’idea). La forza di gravità avvertita, per esempio, dalla Terra nei confronti del Sole, è il risultato della curvatura del “foglio di gomma” quadridimensionale causata dalla massa del Sole stesso.