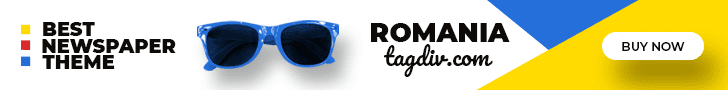Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Il 25 aprile non è solo una data da calendario o una giornata di commemorazioni istituzionali: il giorno della Liberazione è un crocevia storico e simbolico, il punto di svolta in cui l’Italia ha scelto – non senza dolore e lacerazioni – di voltare pagina, liberandosi dal nazifascismo e ponendo le basi della Repubblica. Ma come si è arrivati a quel giorno del 1945? Qual è il significato profondo della Liberazione? E perché oggi, in un’Italia finita politicamente a destra, continua a dividere?
L’armistizio del 1943 e la nascita della Resistenza
La Liberazione non è un evento improvviso, ma l’esito di un lungo e drammatico processo iniziato due anni prima, l’8 settembre 1943, quando l’Italia firmò l’armistizio con gli Alleati. Quel giorno, il re Vittorio Emanuele III e il maresciallo Pietro Badoglio abbandonarono Roma, lasciando l’esercito senza ordini e il paese in balìa del caos. Gli ex alleati tedeschi divennero occupanti, mentre Benito Mussolini, liberato dai paracadutisti tedeschi dopo l’arresto del 25 luglio, fondò la Repubblica sociale italiana (Rsi) nel nord, con l’appoggio del Terzo Reich.
Fu in quel momento che nacque la Resistenza: un movimento popolare spontaneo, eterogeneo, non privo di contraddizioni, che raccolse militari sbandati, giovani renitenti alla leva, operai, contadini, studenti, sacerdoti e intellettuali. Uniti dalla volontà di combattere l’occupazione nazista e i fascisti della Rsi, i primi nuclei partigiani si formarono nelle montagne e nei boschi, dando vita a una nuova forma di guerra: una guerriglia diffusa, asimmetrica, che coinvolgeva non solo le armi, ma anche la società civile.
La guerra di popolo e la repressione
La Resistenza fu anche una guerra sociale. I grandi scioperi del marzo 1944 nel triangolo industriale di Milano, Torino e Genova rappresentarono l’unico caso in Europa occupata di mobilitazione operaia su larga scala. Le azioni dei Gap (Gruppi di azione patriottica) portarono la lotta in città, tra attentati e sabotaggi. Le staffette partigiane – spesso giovani donne – garantivano i collegamenti tra le brigate, portavano viveri e armi, raccoglievano informazioni.
Ma la risposta nazifascista fu brutale. Le stragi delle Fosse Ardeatine, dove furono trucidati 335 civili, e di Marzabotto, con oltre 1.800 vittime, sono solo gli esempi più noti di una repressione sistematica. La guerra civile italiana, come l’ha definita lo storico Claudio Pavone, fu anche uno scontro tra due visioni del mondo: da un lato l’ideale democratico e antifascista, dall’altro il culto dell’ordine, della gerarchia, della violenza come strumento politico.
L’insurrezione dell’aprile 1945
Con l’arrivo della primavera del 1945, il periodo bellico si avvicinava alla conclusione. Gli Alleati, dopo aver sfondato la Linea Gotica, avanzavano rapidamente verso il nord. Il Comitato di liberazione nazionale alta Italia (Clnai), guidato da figure come Sandro Pertini, Ferruccio Parri e Luigi Longo, decise di anticipare l’arrivo delle truppe alleate e proclamare l’insurrezione generale per il 25 aprile.